di Franco Cesati Editore
Nella vita dello stud ente universitario medio, arriva sempre quel momento: quello in cui si invoca un po’ di sana “pratica”, dopo anni di teoria e di volumi da sottolineare. Quello in cui vuoi capire se tutte le informazioni che risiedono ormai nella tua mente, troveranno mai uno sbocco, serviranno mai davvero, anche solo a pagarti l’affitto. Per questo, la parola “laboratorio” ha catturato subito la mia attenzione, mentre scorrevo l’elenco degli ultimi esami a scelta del corso di laurea in Linguistica: di per sé dà l’idea di qualcosa che si crea, che si fa, che si produce. E poi il resto: “di italiano scritto”. Scrivere già lo facevo, ma saper scrivere è un altro paio di maniche; in più stavo per preparare la tesi: inutile aggiungere che mi ci sono fiondata.
ente universitario medio, arriva sempre quel momento: quello in cui si invoca un po’ di sana “pratica”, dopo anni di teoria e di volumi da sottolineare. Quello in cui vuoi capire se tutte le informazioni che risiedono ormai nella tua mente, troveranno mai uno sbocco, serviranno mai davvero, anche solo a pagarti l’affitto. Per questo, la parola “laboratorio” ha catturato subito la mia attenzione, mentre scorrevo l’elenco degli ultimi esami a scelta del corso di laurea in Linguistica: di per sé dà l’idea di qualcosa che si crea, che si fa, che si produce. E poi il resto: “di italiano scritto”. Scrivere già lo facevo, ma saper scrivere è un altro paio di maniche; in più stavo per preparare la tesi: inutile aggiungere che mi ci sono fiondata.
Una ragazza alta, con capelli scuri, percorre a grandi falcate il salone 4 novembre (in via degli Alfani, a Firenze); e, mentre cammina, parla a voce alta verso di noi; e, mentre cammina e parla, ride, gesticola, e poi poggia sulla cattedra sistemata al posto dell’altare, una borsa grande, vari fogli, carte. Intanto, sento vociare accanto a me e davanti: qualcuno si chiede se sia “lei” la docente che terrà il corso. Poi sistema il lungo filo del microfono e si mette proprio di fronte alla cattedra, in piedi: allora è lei. Mi colpiscono subito due cose: l’età – è giovanissima – e il piglio: per chi studia linguistica non è una novità avere dei docenti che parlano in modo chiaro, semplice, senza complicazioni inutili, senza subordinate doppie, triple e carpiate solo per far capire il ruolo che ricoprono in quella circostanza. Anche lei è così: ma all’ennesima potenza. In questo suo modo – al confine tra informalità e informatività – riesce a catalizzare l’attenzione di cento studenti, a volte distratti, a volte affamati, a volte assonnati; a volte presi dall’esame che devono passare a tutti i costi; a volte, tutto questo insieme. Le sue lezioni sono un collage: prende le definizioni di de Beaugrande e Dressler, ci appiccica sopra espressioni del lessico giovanile, aggiunge consigli di libri da leggere, esempi “vivi”, tratti da chat, mail, sms, rimanda al Gradit di De Mauro e poi ai dati sulla lettura in Italia. Ma non si limita a questo: chiede, interagisce, coglie le battute e le frasi dette a mezza bocca dai ragazzi e li trasforma in esempi d’uso, in “ganci” per ripescare qualcosa di già detto o per passare a un nuovo argomento. Insomma, le sue lezioni sono uno spasso: ciò che dice ti rimane in testa e non sai perché. Cioè, lo sai, ma solo dopo: perché con lei quello che chiamano “filtro affettivo” non esiste. Ne hai rispetto ma non timore, non ti senti giudicato, e allora la tua mente è completamente libera di apprendere, di trasformare le nozioni in ricordi collegati a parole, a immagini, a slide, anche a battute scherzose; perché no, anche alle parolacce: perché della lingua si studia tutto, senza pregiudizi.
La prima lezione che ho imparat o dal suo laboratorio è questa.
o dal suo laboratorio è questa.
Poi ho imparato anch’io a venerare la spillatrice – “lo strumento del potere” con cui dava un ordine ai fogli sparsi delle nostre prove in itinere; a detestare il “salve”, questa scelta ibrida, come se non fossi in grado di scegliere tra il “tu” e il “lei”; a tollerare chi legge fumetti, perché l’importante è leggere, di tutto: anche il bugiardino o il retro della confezione di biscotti. Della linguistica ero già una fan scatenata: lei mi ha mostrato altri modi “di” esserlo.
E poi ad avere sempre dubbi, perché sono quelli che ti fanno fare un passo in avanti; che bisogna saper cercare, saper leggere, sapersi informare, insomma: essere consapevoli.
Diversi anni dopo, ho finalmente capito a cosa mi sarebbero servite tutte le informazioni, le nozioni che avevo interiorizzato, tutti i libri che avevo comprato durante gli anni universitari (perché bisogna comprarli, i libri): a fare la redattrice per la Franco Cesati Editore. (Mi sarebbero serviti comunque, naturalmente, ma provate a correggere un manuale di linguistica senza aver mai sentito parlare di Saussure o di continuum).
Ho sempre un’idea in testa: che i libri, tutti i libri, insegnino qualcosa, anche “loro malgrado”; anche quelli terribili, abominevoli che affollano le vetrine o gli scaffali d’ingresso delle librerie. Quanto avrebbero potuto insegnare dei libri scritti a misura di lettore, che racchiudessero in poche pagine la giusta dose di informazioni base su un argomento (legato alla lingua o alla letteratura). “Giusta” perché scattasse nel lettore una molla, la più potente: la curiosità, la voglia di leggere ancora, altro, qualcosa che approfondisca, confuti o confermi, le parole appena lette.
Di qui “pillole”, una collana di grande divulgazione, scritta da linguisti e letterati ma senza che questi si sentano in cattedra e i lettori allievi “passivi”. Una serie di libri robusti da un punto di vista scientifico, ma leggeri, di una leggerezza calviniana, accessibili anche per un pubblico di non esperti. E non esaustivi per definizione (a patto che un libro possa mai esserlo sul serio).
Inutile dire che tra i primi nomi che mi sono subito venuti in mente c’è stato quello di Vera Gheno: il “laboratorio di italiano scritto” che avevo frequentato era ormai lontano ma avevo ancora in mente quell’immagine di lei davanti alla cattedra e non “in” cattedra a spiegare, insegnare, confrontarsi. In più, di uditori distratti, affamati, assonnati, ne aveva visto passare parecchi negli anni di corsi, dunque sapeva come instillare “quella” scintilla, la curiosità per l’appunto.
L’idea del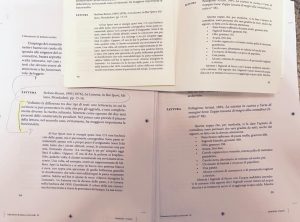 la “Guida pratica all’italiano scritto” nasce così, e credo sia proprio un bel modo: perché dimostra che chi riesce a insegnarti qualcosa, alla fine te lo porti dietro, anzi dentro. Perché tutte le informazioni che non si perdono per strada si prendono, si assorbono, diventano parte di un bagaglio che si riempie ogni giorno, lì dove stanno tutte le tue conoscenze, le tue competenze; da cui attingi quando ne hai bisogno. E infatti io la mia copia della “Guida pratica” la tengo a portata di mano sulla scrivania, accanto alla Grammatica di Serianni, ai libri della Carrada, al manuale di stile Zanichelli; quel libro verde a lunghissima gestazione ma nato in poco meno di un anno.
la “Guida pratica all’italiano scritto” nasce così, e credo sia proprio un bel modo: perché dimostra che chi riesce a insegnarti qualcosa, alla fine te lo porti dietro, anzi dentro. Perché tutte le informazioni che non si perdono per strada si prendono, si assorbono, diventano parte di un bagaglio che si riempie ogni giorno, lì dove stanno tutte le tue conoscenze, le tue competenze; da cui attingi quando ne hai bisogno. E infatti io la mia copia della “Guida pratica” la tengo a portata di mano sulla scrivania, accanto alla Grammatica di Serianni, ai libri della Carrada, al manuale di stile Zanichelli; quel libro verde a lunghissima gestazione ma nato in poco meno di un anno.
Dopotutto, di materiale scritto, preparato e testato “sul campo” durante gli anni del suo laboratorio, Vera ne aveva tantissimo; si trattava di metterlo insieme in modo ragionato, di trasformarlo in un testo fluido, uniforme, di adattarlo. Insomma, lei per prima avrebbe dovuto mettere in pratica tutti i consigli di pianificazione e scrittura che poi sarebbero diventati i capisaldi del suo libro. Per questo credo il testo “funzioni”: perché centra l’esigenza del lettore di sapere “come” si scriva; insomma, il fatto che sia “testato su degli umani” è la sua cifra; lo stile, il suo valore aggiunto.
Ma che avrebbe avuto così tanto successo, l’avremmo saputo solo dopo.
In quel momento c’era da scrivere (per lei);  per me, da superare il complesso dell’allieva perché, di fronte a un insegnante, allievi ci si sente sempre, anche a quarant’anni (e temo oltre). La conferma l’ho avuta il giorno della presentazione della “Guida pratica” all’Ibs-Libraccio di Firenze: la sala affollata, gli autografi, tutto bene, ma quel che a Vera importava di più (oltre ad avere vicino le persone care) credo fosse l’opinione di Nicoletta Maraschio sul suo libro: il suo primo libro. E, in qualche modo, anche il mio: per il motivo di cui sopra e perché credo fortemente sia un testo necessario – e c’è un enorme bisogno di testi così.
per me, da superare il complesso dell’allieva perché, di fronte a un insegnante, allievi ci si sente sempre, anche a quarant’anni (e temo oltre). La conferma l’ho avuta il giorno della presentazione della “Guida pratica” all’Ibs-Libraccio di Firenze: la sala affollata, gli autografi, tutto bene, ma quel che a Vera importava di più (oltre ad avere vicino le persone care) credo fosse l’opinione di Nicoletta Maraschio sul suo libro: il suo primo libro. E, in qualche modo, anche il mio: per il motivo di cui sopra e perché credo fortemente sia un testo necessario – e c’è un enorme bisogno di testi così.
Vera consegna il suo scritto in meno di sei mesi, così iniziamo i giri di bozze, gli appuntamenti in redazione alle 14.30 per discutere delle correzioni e del layout più adatto: perché anche il modo in cui le nozioni sono sistemate “fisicamente”, graficamente su una pagina sono fondamentali e mai casuali. Qui, essenziale era non creare “muri di testo”, far respirare la pagina (e il lettore) attraverso elenchi puntati, focus sui consigli utili, elementi che permettessero di trovare le informazioni importanti a colpo d’occhio, senza doverle ricercare con la lente d’ingrandimento o leggere per forza tutta la pagina. I libri di consultazione devono essere così: perché non si leggono solo in orizzontale, dall’inizio alla fine, ma anche in verticale, quando “ci salti dentro” in preda a un dubbio amletico o quando vuoi rafforzare una certezza.
In uno di quei pomeriggi, Vera arriva in redazione, e guarda con due occhi così la mia scrivania: lì c’è la ciano del suo libro verde – la prova di  stampa della “Guida pratica”, finalmente su formato e carta Fedrigoni, la nostra carta avorio. Io le dico che è “solo” una prova ma per lei è “lui”: il suo “librino”. Quell’espressione, un misto di entusiasmo e di emozione, è quella che si dovrebbe avere sempre di fronte a un libro che nasce, a un progetto che si realizza e alle persone che ci credono e si spendono.
stampa della “Guida pratica”, finalmente su formato e carta Fedrigoni, la nostra carta avorio. Io le dico che è “solo” una prova ma per lei è “lui”: il suo “librino”. Quell’espressione, un misto di entusiasmo e di emozione, è quella che si dovrebbe avere sempre di fronte a un libro che nasce, a un progetto che si realizza e alle persone che ci credono e si spendono.
La “Guida pratica” è in libreria da mesi e ha trovato spazio sullo scaffale di molte librerie, sulla scrivania di molti, a parte la mia. Ha trovato la sua strada, anzi, le sue strade. Lì dove si incrociano le persone.
Silvia Columbano